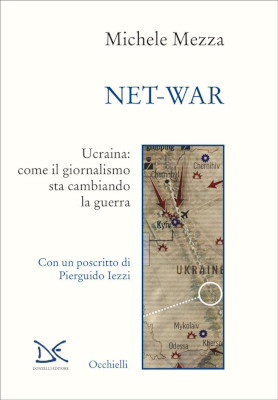Un’opposizione che si rispetti, in parlamento e fuori, dovrebbe essere “ideologica”, come si dice con un termine piuttosto approssimativo, e al tempo stesso “nel merito”. Per esempio, Giorgia Meloni, che ha studiato le lingue, si è autodefinita una underdog – una “sottocane”, si potrebbe tradurre alla lettera, un po’ per ridere, pensando alla sua discendenza da “cani” di ben altra rabbiosa violenza. Più precisamente, una “svantaggiata” o addirittura una “diseredata”: una persona che non ha santi in paradiso, come si direbbe a Napoli, che cioè si è fatta da sé e viene dal basso. Bene, un discorso che apparirà ideologico consiste nel sottolineare come un regime reazionario di massa derivi proprio dalla combinazione dei due aspetti: dal sovversivismo delle classi dirigenti, come lo chiamava Gramsci, pronte a correre qualsiasi avventura pur di difendere i propri interessi (nel caso italiano odierno si tratta soprattutto del blocco borghese del Nord, che vota indifferentemente per la Lega o Fratelli d’Italia), e dal rampantismo di qualcuno proveniente dai ceti popolari. Una ragazza della Garbatella cresciuta senza padre, in questo senso, è perfetta. Su di lei possono proiettarsi e convogliarsi tutte le frustrazioni – anche una femminile volontà di rivalsa priva di femminismo – che la nostra società produce e riproduce senza posa. Tuttavia, questo è il punto, secondo l’interesse prevalente degli altri, ossia di quelle classi dirigenti che intendono lasciare invariato lo status quo. Sembra una rivolta – ed è una conferma degli equilibri esistenti.
L’amalgama scomposto dei più poveri con i più ricchi, o tra chi ha potere e chi non ne ha, è infatti il segreto dei populismi contemporanei. Di essi Meloni, in Italia, non è che il più recente avatar – avendo il nostro Paese conosciuto, con il partito azienda di Berlusconi, ormai quasi trent’anni fa, l’irruzione nella scena politica di un populismo mediatico e privatistico: qualcosa che, con l’apporto della Lega (Umberto Bossi, come Meloni, era anche lui un “figlio del popolo”), confermava gli interessi di quelli che, come si sa, tendono a pagare meno tasse possibile, mettendo i propri dipendenti in una condizione di “servitù volontaria” grazie all’attivismo del loro “fare impresa”.
Ora, la ragione per cui – a volere entrare nel merito di uno dei temi sul tappeto – siamo a favore dell’introduzione di un salario minimo (è anzi uno scandalo che in Italia non ci sia ancora) e contrari, invece, a sconti fiscali per gli imprenditori che assumano, è perché la forza-lavoro, nel secondo caso, rimarrebbe invischiata nella dipendenza da questo o quel padrone più disponibile a reclutarla (e bisognerebbe poi vedere a quali condizioni). Le lavoratrici e i lavoratori, con la certezza di un salario minimo, potrebbero magari cercarsi un altro impiego se quello ottenuto si rivelasse un disastro. Un salario minimo, stabilito per legge, tende quindi a liberare le lavoratrici e i lavoratori dalla dipendenza, sia pure in piccola parte; invece gli sconti fiscali alle imprese confermano un viluppo di interessi contrastanti, entro cui si riaffermano quelli più forti.
Un analogo ragionamento potrebbe essere svolto intorno al reddito di cittadinanza, che in Italia poi non è altro che un sussidio di disoccupazione. Il suo principio, al di là di questa o quella stortura, consiste nello svincolare il reddito dalla prestazione lavorativa: una persona, per il semplice fatto di esistere, ha diritto alle risorse che gli permettano di vivere. Ciò vorrebbe dire contribuire a liberare la vita sociale dalla egemonia del mercato.