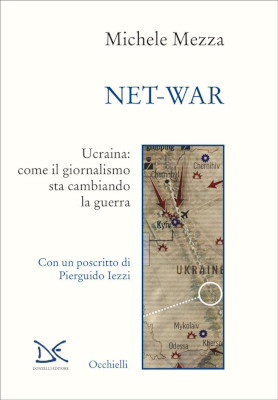ffffffffffffff: Sinistra o “riformismo”?
ffffffffffffff: Sinistra o “riformismo”?
Non usò mezzi termini, nel 2002, Sergio Cofferati, allora segretario generale della Cgil, nel definire il “riformismo”. “È una parola malata” – disse il “cinese”, come viene chiamato l’ex sindacalista per via dei suoi occhi a mandorla. Stando a quanto riporta il giornalista ed ex dirigente comunista, Aldo Pirone, in un articolo pubblicato dalla testata online “Strisciarossa”, la risposta dai piani alti (si fa per dire) dei Democratici di sinistra, guidati in quel momento da Piero Fassino, non si fece attendere. Offesi come furono da quel giudizio, che stigmatizzava un sostantivo diventato ormai sinonimo di neoliberismo, una mutazione infiltratasi nel Dna degli ex comunisti e di tante altre sinistre nel mondo.
Ma com’è stato possibile che i termini “riformismo” e “riformista” abbiano completamente cambiato significato, diventando qualcosa che con la sinistra non ha più nulla a che vedere? La battaglia senza esclusione di colpi – all’interno di quel mondo, tra quelli che si definivano e operavano come “riformisti” e i “rivoluzionari” – fu un elemento di divisione durante tutto “il secolo breve”, come Hobsbawm definiva il Novecento. I primi volevano cambiare attraverso delle riforme la società, migliorando le condizioni dei lavoratori, aumentandone nel contempo il potere contrattuale e politico, sempre con l’obiettivo di realizzare una società socialista; stesso obiettivo, quello dei rivoluzionari, da raggiungere però con un atto violento contro il vecchio mondo reazionario. La famosa “presa del Palazzo d’inverno”, come fu quella di Lenin e dei bolscevichi in Russia. La spaccatura si evidenziò plasticamente dopo la rivoluzione d’Ottobre, ed ebbe ripercussioni importanti nella sinistra internazionale.
In Italia, determinò la drammatica scissione di Livorno del 1921, con la conseguente nascita del Partito comunista d’Italia di Bordiga, Gramsci, Togliatti, che guardavano a Mosca, definendosi rivoluzionari contro il padre storico del socialismo e del riformismo italiano, Filippo Turati. In mezzo, i socialisti massimalisti, anch’essi rivoluzionari, ma che ritenevano importante mantenere aperto un dialogo con l’ala più moderata del partito. Un quadro che si riprodusse, più o meno negli stessi termini, nella sinistra di tutto il mondo.
Durante e dopo la Seconda guerra mondiale, la divisione non si riprodusse come in precedenza e con la stessa nettezza. Le priorità, in quel drammatico periodo storico, erano combattere il nazifascismo e ripristinare la democrazia. In questo contesto, non c’era certo spazio per “fare come in Russia”. Ma dopo la guerra – soprattutto tra i comunisti, in particolare tra molti partigiani e militanti di base – si fece fatica a mettere da parte l’idea di una presa armata del potere. E restò per anni l’idea che, in fondo, dietro l’apparenza riformista del Partito comunista italiano – i cui dirigenti preferivano definirsi però “riformatori” –, fossero rimaste velleità rivoluzionarie. Il film Berlinguer ti voglio bene rende bene questa dimensione, quando un divertentissimo Roberto Benigni, nella parte di un lavoratore edile, auspica l’arrivo del segretario del Pci e un suo “via”, un “ok, procedete, è giunta l’ora della rivoluzione”.
I “fatti di Ungheria” del 1956, e il sostegno del Pci di Palmiro Togliatti all’invasione sovietica, ribadirono, sia pure in un modo improprio – i carri armati a Budapest non potevano facilmente essere presentati come un atto rivoluzionario –, la divisione tra le due tendenze. In particolare, mostrarono la “doppiezza” del segretario e del partito, anche se, contemporaneamente, venivano poste le basi per attuare quella grande quanto unica – osservata e ammirata con attenzione in tutta Europa – azione riformista nelle “regioni rosse” (Emilia Romagna, Toscana e Umbria), che portò grandi progressi sociali in un’area divenuta, con il tempo, tra le più ricche d’Italia.
Pochi anni dopo, nel 1962, cominciò a prendere corpo un riformismo governativo: un’alleanza che spostò a sinistra l’asse politico del Paese. In un primo momento, con l’esecutivo tripartito di Amintore Fanfani, che vide la Democrazia cristiana alleata con il Partito socialdemocratico e i repubblicani, con l’astensione dei socialisti. Malgrado non si trattasse ancora di un vero centrosinistra, attuò alcune importanti riforme, come l’istituzione della scuola media unica obbligatoria, la nazionalizzazione delle aziende elettriche e l’istituzione dell’Enel. Misure che oggi, solo a nominarle, farebbero venire il mal di pancia a quasi tutti i partiti politici. Il 4 dicembre del 1963, con Aldo Moro, arrivò il primo governo di centrosinistra organico, imperniato sull’alleanza dei democristiani con i socialisti di Pietro Nenni – una formula che destò più di una preoccupazione dall’altra parte dell’oceano –, insieme con i socialdemocratici e i repubblicani. Tra alterne vicende e finanche minacce di colpi di Stato (caso Sifar), il centrosinistra terminava la sua esperienza nel 1968, chiudendo una parentesi interessante ed evolutiva nella storia del riformismo italiano.
Quasi contemporaneamente, se ne aprì un’altra, sotto la spinta innovatrice, per certi versi rivoluzionaria – a voler prendere per buona l’interpretazione dei gruppi e dei piccoli partiti a sinistra del Pci –, che, dalla fine degli anni Sessanta a tutti gli anni Settanta, fece fare all’Italia straordinari passi avanti sul terreno dei diritti sociali e civili. Un grande periodo, insomma, fatto di riforme realizzate anche grazie al contributo del Pci, che nel frattempo stava registrando un aumento importante dei propri consensi elettorali. Mediante una maggioranza legislativa, che si sostituì talvolta a quella puramente di governo, considerata l’assenza dei comunisti dalla “stanza dei bottoni”, vennero promulgate leggi straordinarie. Dallo Statuto dei lavoratori alla riforma del sistema sanitario nazionale. Dalla legalizzazione dell’obiezione di coscienza al nuovo diritto di famiglia, con l’approvazione della legge sul divorzio. Da quella sull’interruzione volontaria di gravidanza al superamento dell’ospedale psichiatrico, con l’attivazione dei servizi di salute mentale. E la lista potrebbe continuare. Indubbiamente, il momento più esaltante del riformismo italiano – una stagione irripetibile.
Nello stesso periodo, partiva l’offensiva neoliberista, tuttora ben lungi dall’essere collocata negli armadi della storia. Il reaganismo e il thatcherismo dichiararono guerra al modello keynesiano, mettendo in pratica quanto insegnato dall’economista Milton Friedman e i suoi Chicago boys, le cui ricette trovarono una prima drammatica sperimentazione nel Cile di Pinochet, che nel 1973 aveva rovesciato con un sanguinoso colpo di Stato il governo – appunto riformista – del socialista Salvador Allende.
In Italia, la stagione delle riforme, quelle progressiste, stava conoscendo la parola fine. Con l’avvento di Bettino Craxi alla segreteria del Partito socialista, da un lato, e il lento declino del Partito comunista, dall’altro, cominciò l’era delle riforme di destra che smantellarono, o tentarono di farlo, le conquiste di quell’incredibile decennio.
Con la cosiddetta seconda Repubblica, la sinistra tentò di contrastare l’arrivo di una destra aggressiva, facendo propria la logica del riformismo liberista e delle privatizzazioni. La sanità venne aziendalizzata con l’introduzione delle Asl (Aziende sanitarie locali), e con cospicui finanziamenti alla sanità privata. Stesso scenario sul fronte pensionistico, dove l’avvilimento di uno dei diritti fondamentali della vita di una persona determinò l’emergere del settore privato – ovviamente per chi poteva permetterselo. Al centro di tutto, la drammatica precarizzazione del lavoro, che colpì e colpisce ancora soprattutto i più giovani. Fu, ed è, la penetrazione di elementi di “americanizzazione” in Italia e in Europa, che invece in precedenza aveva brillato nella tutela degli individui “dalla culla alla tomba”.
Non è, del resto, che si debba guardare soltanto all’oggi per trovare forti elementi di fascinazione, da parte della nostra sinistra, che non si oppose, e anzi assecondò, quella deriva. L’allora segretario dei Democratici di sinistra, Massimo D’Alema, negli ultimi anni riciclatosi a sinistra, guardò con attenzione alla “terza via” del premier britannico Tony Blair e del presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Proprio in quella fase di inizio millennio, Rossana Rossanda pose con nettezza (in un articolo sul “manifesto”) il tema del riformismo in chiave liberista: “Con le proposte di partito riformista unico – sottolineava la giornalista, con riferimento ai postcomunisti – si va verso la liquidazione formale del più grande partito della sinistra italiana. Nella sostanza – aggiungeva Rossanda – essa è già avvenuta per passaggi successivi dalla svolta a oggi, con gli scivolamenti semantici progressivi a proposito del riformismo, che doveva ridurre il potere del capitale sul lavoro e oggi consacra l’opposto, e sulla transizione che designava il passaggio dal capitalismo a forme di socialismo e oggi indica il processo inverso”.
Tutto ciò ossessiona ancora oggi l’erede malato di quella tradizione, il Partito democratico. Quando si deve accusare qualcuno di essere “populista” – altro termine usato spesso a sproposito –, lo si fa nel nome del riformismo. Un tema che turba i sonni dell’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, i cui sodali rimasti nel Pd hanno costituito il gruppo, appunto, di “Base riformista”. Termine, quello di “riformista”, che piace molto anche al leader di Azione, Carlo Calenda. Blair definì Renzi “mio erede, che con la sua corsa alle riforme cambierà l’Italia”. Le cose non sono andate esattamente così; ma il dilemma – essere riformista oppure guardare a sinistra e ai 5 Stelle – rischia di decomporre il principale partito – non sappiamo ancora per quanto tempo – progressista italiano. Con allarmanti, e ancora imprevedibili, ripercussioni sulla democrazia del nostro Paese. Ma sempre in nome del riformismo.